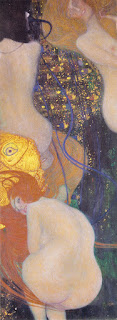Attraversare
un ponte formato da una lunghissima spada: questa la prova più
difficile che Lancillotto dovette affrontare per entrare nel regno di
Gorre e liberare l'amata regina Ginevra dalle grinfie del perfido
Méléagant. Il pericolo era duplice: ferirsi mortalmente con la lama
e precipitare nel fiume: “d'acqua traditrice, nera e rumoreggiante,
densa e scura orrida e spaventosa come un fiume dell'inferno, tanto
pericolosa e profonda che chi vi fosse caduto si sarebbe sicuramente
perso”. Questa è la paurosa rappresentazione che Chrétien de
Troyes fa dell'unica via di passaggio a disposizione dell'eroe il
quale - sprezzante del dolore –si toglie l'armatura e
tagliuzzandosi sulla lama passa dall'altra parte, malconcio ma
vittorioso. Il poeta francese, vissuto nella seconda metà del XII
secolo, quando descrive il “ponte della spada” non parla
evidentemente di una costruzione reale ma allude a una metafora:
l'eroe può raggiungere il suo scopo solo superando una prova
rischiosissima.
Lo
stesso tema lo si ritrova nelle tradizioni esoteriche dell'antica
Cina dove il viaggio iniziatico verso la conoscenza si compiva
attraversando ponti di metallo che alludevano a segrete operazioni
alchemiche. La tradizione islamica invece narra di come per giungere
al paradiso si debba effettuare lo Sirât, l'attraversamento di un
ponte sottile come un capello che solo gli eletti riusciranno a
superare laddove i dannati verranno precipitati all'inferno. Ma ci
sono ulteriori significati da esaminare: i ponti uniscono Cielo e
Terra, il Divino col Mortale come il Bifröst della mitologia
scandinava formato da un arcobaleno che arriva fino al mondo degli
dei. Costruire un ponte nell'antichità era inoltre considerata una
profanazione delle acque, cariche di valenze sacrali, e forse per
questo quando i romani si accinsero a realizzare il primo ponte sul
divino Tevere - il Sublicio, interamente in legno - lo affidarono al
Pontifex Maximus (da cui deriva il nome del Pontefice cristiano)
l'unico autorizzato alla sua manutenzione e che ogni anno placava la
collera del fiume gettandoci dentro ventisette fantocci di giunchi,
probabile ricordo di sacrifici ben più cruenti.
 Qualcuno
dirà: sono solo vecchie storie. Ma il fascinoso simbolo del ponte
compare spesso nei sogni dell'uomo moderno a dimostrazione della sua
innegabile vitalità: superare un ostacolo tra due mondi, unire
aspetti contrastanti, attraversare un posto pericoloso da cui
rischiamo di precipitare. Alcuni periodi della vita sono – come i
ponti - passaggi da uno stato all'altro (nascita, infanzia,
adolescenza, maturità, vecchiaia e morte) che comportano momenti di
crisi e di riadattamento a nuove situazioni, come se ci
incamminassimo verso terre inesplorate.
Qualcuno
dirà: sono solo vecchie storie. Ma il fascinoso simbolo del ponte
compare spesso nei sogni dell'uomo moderno a dimostrazione della sua
innegabile vitalità: superare un ostacolo tra due mondi, unire
aspetti contrastanti, attraversare un posto pericoloso da cui
rischiamo di precipitare. Alcuni periodi della vita sono – come i
ponti - passaggi da uno stato all'altro (nascita, infanzia,
adolescenza, maturità, vecchiaia e morte) che comportano momenti di
crisi e di riadattamento a nuove situazioni, come se ci
incamminassimo verso terre inesplorate.
Naturalmente
i ponti sono anche opere di architettura e ingegneria, e al giorno
d'oggi meravigliose e arditissime costruzioni che sono meta del
turismo di massa (a ulteriore dimostrazione che l'immagine del ponte
è tuttora capace di emozionare): il Phiton Bridge ad Amsterdam, il
pedonale Henderson Waves a Singapore, il Zhivopisny a Mosca, il
Tianjin bridge in Cina - l'unico munito di ruota panoramica – e
infine il più lungo di tutti, quasi quattro chilometri, l'Akashi
Kaikyō in Giappone. Ma non è di questo che qui si vuole parlare,
semmai di quelli che affondano la loro tradizione nella storia e in
diversi casi nella leggenda.
Possiamo
pensare che i primi cacciatori e raccoglitori umani utilizzassero
tronchi di legno o liane intrecciate per passare attraverso torrenti
o burroni, ma la necessità di costruire più robuste strutture in
muratura si fece sentire abbastanza presto se Erodoto racconta che
esisteva un ponte in pietra che a Babilonia congiungeva le due rive
dell'Eufrate.
Attraversare un grande fiume non doveva essere una
questione facile a quei tempi, e infatti quando si doveva portare un
esercito da una sponda all'altra si ricorreva ad otri gonfiati d'aria
a cui si aggrappavano i soldati, manovra ripresa anche da Alessandro
Magno per varcare il Danubio. In Italia dobbiamo i primi ponti agli
etruschi, che i romani detestavano al punto da finire per cancellarli
dalla faccia della terra, non senza avergli prima copiato la
fondamentale invenzione architettonica dell'arco. Nella sua conquista
dell'Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente Roma disseminò di
strade e ponti tutto l'impero, eseguiti con tale maestria che molti
sono tuttora esistenti e in funzione; Giulio Cesare ne volle
addirittura edificare uno in legno sul Reno, cosa che gli riuscì in
una decina di giorni, e solo per dimostrare ai Germani quanto lui
fosse bravo e potente. I barbari impressionati se la diedero a gambe
e poco dopo il proconsole fece distruggere il suo capolavoro, mentre
storici e archeologi sono ancora lì che si chiedono come abbia fatto
a realizzarlo in così poco tempo e su un fiume come il Reno, non
proprio un ruscello. E' noto che i romani furono ingegneri
eccezionali: riuscirono a costruire il sistema delle fondazioni
sott'acqua e con Traiano arrivarono a fabbricare un ponte sul Danubio
- oggi purtroppo distrutto - lungo più di un chilometro e dotato di
venti arcate.
Nel
medioevo la competenza dei costruttori di ponti non venne meno, ma in
un'epoca superstiziosa in cui chiese e cattedrali si affollavano di
figure mostruose, e i bestiari si popolavano di draghi ed animali
fantastici, la messa in opera di questo tipo di manufatto fu
attribuita quasi esclusivamente al Demonio, i cui servizi si
moltiplicarono spinti da una fortissima domanda. Dal 1000 al 1600
circa sorsero in tutta Europa moltissimi Ponti del Diavolo, tutti
associati a leggende praticamente simili: un muratore o un architetto
fortemente in ritardo scende a patti col diavolo che gli promette di
costruirgli il ponte in una notte, purché gli venga ceduta la prima
anima che lo oltrepasserà. Il mattino dopo l'astuto artigiano farà
attraversare un animale (di solito una capra o un cane, i gatti son
troppo furbi) e il maligno resterà gabbato. Anche qui il ponte
allude a una situazione pericolosa che terminerà con la sconfitta
del male come agente di divisione (il significato della parola
“diavolo” deriva dal verbo greco “dia-bàllein”, che
significa “separare, creare fratture”). Molti ponti antichi e
moderni sono inoltre associati a storie sinistre: il loro ben
visibile stato di luogo di passaggio permetteva di esporre come
monito alla popolazione le teste dei giustiziati o di impiccarvi
qualche malcapitato: è il caso di ponte Sant'Angelo a Roma o di
quello di Teramo, detto in dialetto de “li impisi”. Le esecuzioni
sui ponti sono andate avanti fino al giorno d'oggi: nel 1992 quello
bosniaco di Višegrad sulla Drina fu il testimone silenzioso di una
spietata pulizia etnica e ancor più di recente una presunta spia
irachena è stata impiccata dall'Isis al ponte di Fallujah.
Una
novità medievale furono costruzioni fiancheggiate da case e
botteghe, come il Ponte Vecchio a Firenze dove anticamente il governo
cittadino volle collocare il mercato della carne che, tra banchi di
lombate, costate, ossa e frattaglie malamente conservate, doveva
puzzare un bel po' e quindi essere allontanato dalle sensibili narici
dei fiorentini. Ponti di questo tipo sorsero un po' dappertutto,
anche perché nelle città circondate da mura lo spazio a
disposizione per costruire diventava sempre più scarso man mano che
la cittadinanza infittiva. Se in Francia ce n'erano ben trentacinque
– tre anche a Parigi, sull'Ile de la cité - il ponte abitato più
famoso di tutti fu il London Bridge, edificato tra il 1176 e il 1209
e da non confondersi con l'attuale Tower Bridge, molto più tardo.
Munito di ruote idrauliche e cancelli che venivano chiusi durante il
coprifuoco, il ponte di Londra arrivò a contenere fino a 200
attività commerciali, numerosi appartamenti e perfino una cappella
dedicata al santo e martire Thomas Becket. Anche qui c'era
l'abitudine di esibire sulle picche le teste mozzate dei traditori,
che venivano bollite e incatramate per proteggerle e prolungare il
macabro spettacolo; molti crani famosi dondolarono dal ponte, tra cui
quelli del ribelle William Wallace (avete mai visto Braveheart?) e
del cancelliere e umanista Thomas More che aveva ostacolato il
matrimonio di Enrico VIII con Anna Bolena. Con la modernizzazione
ottocentesca il London Bridge, stretto, scomodo e soggetto a crolli e
incendi, fu abbattuto e sostituito, cosa che giovò al traffico ma
fece perdere la testimonianza indimenticabile d'un pezzo di storia
inglese.
Sporgersi
dalla spalletta di un ponte e guardare sotto può essere uno
spettacolo emozionante: è quello che succede quando ci si affaccia
dal ponte di Ronda, vicino a Malaga, che unisce la città vecchia a
quella nuova, passando su una gola profonda fino a 120 metri, detta
“El Tajo”, causata dall'erosione del fiume Guadalevin. Se si
vuole invece intraprendere una traversata alla Indiana Jones occorre
andare in oriente dove esistono ponti sospesi fatti di bambù o di
instabili e tarlate assi di legno come quello lunghissimo di
Hussaini, in Pakistan, retto solo da corde e considerato il più
pericoloso del mondo.
Il più alto invece si trova in Cina sulla
Huangshan (letteralmente Montagna gialla), una serie di picchi famosi
per le bellezze paesaggistiche, la stranezza delle formazioni
rocciose, e gli straordinari giochi di luce dovuti alla presenza di
nubi che spesso circondano le vette. Il ponte, detto “degli
immortali” è a ottocento metri di altezza e congiunge due speroni
di roccia: il luogo, che fa parte di un percorso turistico
mozzafiato, quando sale la bruma assume un aspetto fiabesco e
misterioso,facendo dimenticare che la costruzione è del secolo
scorso anche se falsificata con un parapetto in stile cinese antico.
Fonti: